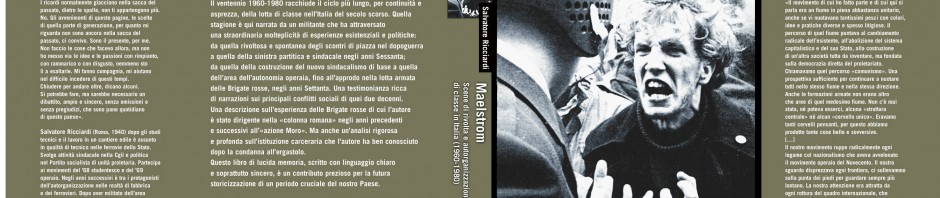Siamo nell’epoca in cui la chiacchiera è in auge. Non da oggi, ma forse oggi più che altri periodi. Alcuni non ne vedono lo scandalo, può darsi, però le numerose chiacchiere profuse dai politici, dai media, dai social, hanno sottratto spazio all’ambito che era deputato al dibattito, anche polemico, su alcune questioni spinose ma importanti della realtà sociale e della politica. Le chiacchiere hanno anche manomesso il linguaggio inquinando i rapporti sociali, al punto che siamo inondati di termini dal significato incomprensibile.
Proverò quindi, su un terreno, per me essenziale, quello della repressione e del carcere, a riportare il dibattito sulla strada di una terminologia appropriata.
La chiacchiera in voga oggi sul carcere, impregnata di pregiudizi, ha imposto la convinzione che le persone che vengono rinchiusa in carcere oltre a perdere la “libertà personale”, definita a ragione “la regina delle libertà”, vedono azzerarsi anche la propria identità e la dignità che configura il valore intrinseco dell’esistenza umana.
Qualche anno fa, era il 2014, Gaetano Silvestri, giudice della Coste Costituzionale, che ne è stato presidente nel 2013 e 2014, in un intervento al Convegno “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU” tenutosi al carcere di Rebibbia, il 28 maggio di quell’anno, ci ha ricordato che il riconoscimento della dignità umana va considerato un valore prioritario e anteriore allo Stato, e non dipendente da questo. Stesso ricordo è stato sollevato e ribadito da Giorgio Lattanzi, attuale presidente, e dai giudici della Corte Costituzionale 4 anni dopo, nel 2018, sempre nel carcere romano di Rebibbia, dando inizio a un ciclo di incontri-dibattiti tra giudici e detenuti e detenute in sette carceri italiani. [questa esperienza ha preso anche la forma di un film: Viaggio in Italia, di Fabio Cavalli, prodotto da Rai Cinema e Clipper Media, che il 5 giugno è stato proiettato per la prima volta]
Ci hanno ricordato, i giudici costituzionali, che il dibattito sulla dignità delle persone recluse è stato ben presente nei lavori dell’Assemblea costituente (insediatasi il 25 giugno 1946), corredandolo con la seguente narrazione: in quella sede, l’onorevole Giuseppe Dossetti, presentò un ordine del giorno, nel quale si affermava l’anteriorità dell’uomo rispetto allo Stato. Su quest’affermazione si registrò la significativa convergenza dell’onorevole Palmiro Togliatti, che affermò come la dottrina marxista, da lui professata, sostenesse che lo Stato dovrà, ad un certo punto, scomparire, mentre sarebbe assurdo pensare che, assieme ad esso, scomparirà la persona umana.
Insomma: la dignità è qualcosa che è dovuta all’essere umano per il semplice fatto che egli è umano. Su questo punto l’Assemblea costituente fu irremovibile!
Questa affermazione di valori, avendo al centro il “pieno sviluppo della personalità umana” ha attraversato i lavori dell’Assemblea e li ritroviamo negli articoli della Costituzione, così come in molte sentenza della Corte costituzionale, che è dovuta intervenire più volte, proprio perché il quadro politico italiano si è dimostrato disattento, se non proprio ostile (il più delle volte), alla piattaforma valoriale delle Carta Costituzionale.
Il rispetto della dignità della persona non implica soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (Art. 27 Costituzione), ma impone che l’esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l’espressione della personalità dell’individuo recluso e l’attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato. Deve farsi strada, quindi, l’idea che la pena debba consentire la ricostruzione di un legame sociale entro una dimensione spazio-temporale che metta il suo destinatario nella condizione di potersi “riappropriare della vita”.
Non è dunque possibile, hanno affermato i giudici della Corte Costituzionale, che lo Stato chieda a chiunque, recluso o internato, il sacrificio della dignità.
Dentro il carcere la restrizione della libertà raggiunge il grado massimo, purtroppo consentito dalla legge, ma la dignità umana deve rimanere integra anche dentro le mura del carcere.
È così che tutti i provvedimenti ulteriormente restrittivi della libertà personale sono di competenza dell’autorità giudiziaria e non dell’amministrazione penitenziaria (sentenza n. 349 del 1993) e la persona detenuta può sempre conferire con il difensore sin dall’inizio dell’esecuzione penale (sentenza n. 212 del 1997).
La dignità umana si sostanzia nel diritto al “rispetto”, sintesi di riconoscimento e di pari considerazione delle persone; in essa libertà ed eguaglianza si fondono. La dignità non si acquista per meriti e non si perde per demeriti, hanno proclamato i costituenti e hanno ripetuto i giudici attuali. Dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana. Ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo, nemmeno allo stato.
L’Assemblea costituente, al suo insediamento individuò alcuni punti nevralgici del sistema sanzionatorio fascista e propose di cambiare completamente il modo di guardare alla condizione detentiva. Non più come uno stato definitivo (codice Rocco), ma come una fase transitoria destinata, nella maggioranza dei casi, ad essere temporanea. L’altro punto che l’Assemblea individuò, per differenziarsi dal regime fascista, fu interpretare la sanzione non come un’emarginazione, una separazione o una ghettizzazione come contemplava il Regolamento Penitenziario del 1931, nello stesso spirito del codice Rocco, ribadendo una netta impermeabilità tra carcere e società e l’esclusione della persona detenuta dal consorzio sociale di cui aveva trasgredito le regole. Al contrario, le deputate e i deputati dell’Assemblea Costituente, decisero che era di vitale importanza stabilire un collegamento stretto tra il dentro e il fuori delle mura carcerarie, affinché la persona condannata e allontanata dal consorzio sociale, potesse ritornarvi come membro riabilitato/a dall’espiazione della pena. Là dove c’era esclusione doveva porsi la tensione rieducativa della pena e, per farlo, era necessario togliere la fissità della pena, la sua rigidità (in tanti, oggi, invocano ottusamente la “certezza della pena”, senza sapere che è un insulto alla Costituzione e si riferisce a tutt’altra cosa) e renderla flessibile, modificabile. E ciò per qualsiasi reato.
Questi che ho appena accennato, sono i principi della Costituzione della repubblica italiana. Purtroppo la realtà del carcere in Italia, sin dal dopoguerra, è stato improntato più alle regole del regime precedente, quello fascista, che non a questi valori esplicitamente posti dalla Costituzione. Difatti il regolamento carcerario fascista del 1931 ha operato fino al 1975, ben 30 anni dopo la liberazione! E nemmeno con la riforma del ‘75, si è riusciti a ribaltare completamente la cultura e il comportamento del sistema della custodia nei confronti delle persone detenute. Evidentemente non c’è stata la convinzione necessaria, nel quadro politico di ieri, sui valori espressi dalla Costituzione. Ha prevalso il timore di scontentare la parte proprietaria e i centri di potere del paese.
Devo dire, per correttezza e per evitare fraintendimenti, che io non mi riconosco completamente nella Costituzione italiana. Almeno per tre motivi: il principio generale della “proprietà privata” che potrebbe essere limitata dalla funzione sociale, ma non succede in questo paese. Io penso debba essere gradualmente sostituita da gestioni collettive. L’altro punto è il riconoscimento della famiglia come società naturale, anche qui penso si debbano esplorare e attivare aggregati più vasti e aperti della famiglia recintata. Il terzo punto è quello della religione e delle religioni, che dovrebbero essere superate, se non altro per i troppi crimini commessi e per la guerra tra poveri che hanno sempre scatenato.
Tuttavia la Carta Costituzionale può costituire un terreno di dibattito e approfondimento verso obiettivi di superamento dell’angusta “logica punitiva”. Obiettivi più ampi e umanamente importanti, come i percorsi collettivi verso orizzonti di liberazione dal lavoro salariato, dal dominio del capitale e dalla repressione omologante. Ma il punto è che l’attuale quadro politico, di governo e di opposizione, è orientato a un sistema di valori totalmente opposti alla Costituzione e funzionali a uno stato di polizia di carattere autoritario.
Non è un caso che oggi, con un quadro politico ancora più ostile alla Costituzione, la realtà del carcere e il dibattito sul carcere si sta allontanando sempre più da quei valori, ritrovandosi a proprio agio nelle leggi e nei regolamenti del regime precedente.
Provo a fare un esempio: la persona detenuta, impegnata in lavorazioni, deve poter svolgere anche le attività collettive e sindacali per il rispetto e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ossia discutere con altri lavoratori-detenuti quali rivendicazioni avanzare e presentarle al datore (Amministrazione o privato). Ogni limitazione all’esercizio di queste e altre attività che non siano strettamente in contrasto con la “sicurezza” acquistano un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, incompatibile con l’art. 27 Cost. (sentenza n. 135 del 2013). Difatti i giudici affermano che la tutela della persona detenuta che operi come lavoratore deve tendere a parificare, nella maggior misura possibile, la condizione del recluso a quella del lavoratore libero, con le sole restrizioni indispensabili alla sicurezza della custodia. Così la sentenza n. 158 del 2001 ha ritenuto non sussistere alcuna giustificazione per la mancata previsione del diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la sua attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria o di terzi.
In conclusione, queste righe vogliono dire che, leggendo attentamente la Costituzione e i “lavori preparatori” per avere un quadro più completo (è scaricabile qui: [V. FALZONE , F. P ALERMO , F. C OSENTINO , (a cura di), La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori, Roma, 1948, 24])* , ne vien fuori una conclusione della progressiva residualità del carcere, a maggior ragione dopo trascorsi 73 anni dall’Assemblea Costituente, in quanto strumento costoso, non adeguato ai compiti di una democrazia, definito ovunque con una icastica affermazione: «an expensive way of making bad people worse» (un modo costoso di peggiorare le persone cattive).
È dunque giunto il momento di porre mano, con determinazione, a un’attività per il suo superamento!
* Che qualcuno/a del quadro politico odierno lo legga è una speranza che non credo si realizzerà. Potrà succedere come nel processo per i fatti di Modena del 9 gennaio 1950, dove poliziotti davanti alle Fonderie Riunite uccisero 6 lavoratori. L’on. Lelio Basso, avvocato delle famiglie dei lavoratori uccisi, domandò al commissario di polizia se sapeva cosa affermasse la Costituzione della Repubblica italiana sull’uso delle armi da fuoco nei conflitti del lavoro. Il commissario rispose secco: «Io dovevo riportare l’ordine davanti alla fabbrica, non avevo tempo di leggere la costituzione». É un po’ questa l’Italia!